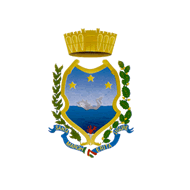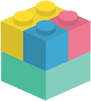Comitato Pari Opportunità dell’Università di Genova
Comitato Pari Opportunità dell’Università di Genova
Abstract - Com’è possibile rendere le istituzioni responsabili del cambiamento che vogliamo vedere in tema di parità di genere? Innanzitutto, che le istituzioni stesse siano responsabili su questo punto è un’idea tutto sommato recente: nasce dalla strategia chiamata gender mainstreaming che si è sviluppata agli inizi degli anni ’90 nell’ambito degli organismi internazionali e sovranazionali. Si tratta di una strategia che permette a chi prende decisioni (i policymaker) di tenere sempre in adeguata considerazione il problema della disparità di genere e di agire per contrastarla. In questo modo, il gender mainstreaming riconosce le discriminazioni di genere come un problema sistemico: non è colpa delle donne o di singoli individui se permangono disparità di genere, nonostante gli sforzi portati avanti nel corso degli ultimi decenni, ma è responsabilità di tutti, soprattutto delle istituzioni, lottare contro queste discriminazioni.
Come avviene questo processo nel concreto? Tramite la raccolta e il monitoraggio dei dati che fotografano la realtà delle disparità di genere, dove fenomeni complessi vengono ricondotti ai loro elementi essenziali. La realtà delle disparità di genere può essere raccontata attraverso un indicatore che considera, per esempio: il salario medio delle donne, il numero di giorni di assenza e la causa, gli episodi di violenza o di molestie, la presenza di donne ai vertici dell’istituzione e molto altro ancora.
I dati sono uno strumento di conoscenza e di potere: sono uno strumento femminista. Ma i dati da soli non raccontano mai un’unica storia, anzi difficilmente ne raccontano una, siamo noi che li facciamo parlare estraendone una narrazione che sia coerente con i nostri valori e le nostre credenze. Per questo è anche necessario che i dati raccolti siano tanti e diversi, perchè meno dati ci sono, minore è il potere di agire per smentire una certa narrazione, o per monitorare una certa situazione. Quando si chiede alle istituzioni pubbliche di raccogliere dati si sta chiedendo loro di mettere in pratica quell’accountability che è nei principi di buon governo, ma allo stesso tempo si sta agendo una responsabilità collettiva e sociale.
- - - - -

Abstract - L’intervento avrà per oggetto “Riflessioni di un’economista sui più recenti sviluppi della letteratura, specie empirica, in tema di corporale social responsibility".
CV
Luca Gandullia. Laureato in economia presso l’Università L. Bocconi di Milano (1989), PhD in economia presso l’Università di Genova (1997), attualmente professore ordinario di scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Ateneo genovese, dove insegna Scienza delle finanze, Finanza regionale e locale ed Economia del settore non profit.
È stato tax economist presso l’OCSE a Parigi (2001-2002). È Delegato del Rettore per l’apprendimento permanente (dal 2020); svolge attività di ricerca in tema di economia della tassazione, federalismo fiscale, economia comportamentale ed economia del settore non profit. È autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali. Recentemente (2022) ha pubblicato per Il Mulino il volume “Ricchezza in eredità. Quale futuro per l’imposta sulle successioni?
Dal 2015 è Presidente di Liguria Ricerche S.p.A. di Regione Liguria.
- - - - -

Abstract - La responsabilità degli investitori nel dialogo con le aziende
Tra gli investitori attenti ai temi di sostenibilità si stanno diffondendo pratiche sempre più ambiziose di engagement, inteso come dialogo con le aziende investite sugli aspetti ESG e come esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario. L'intervento illustrerà le principali evoluzioni di questa strategia, alcune iniziative di successo e le attività promosse dal Forum per la Finanza Sostenibile al riguardo.
Cv
Arianna Lovera è Senior Programme Officer presso il Forum per la Finanza Sostenibile, associazione in cui lavora dal 2015. In precedenza ha lavorato nel settore formativo, educativo e della ricerca presso organizzazioni italiane e straniere, tra cui l’Agenzia per la Formazione e la Ricerca delle Nazioni Unite (UNITAR) e l’Istituto di Studi Politici di Parigi. È autrice di alcune pubblicazioni sul tema della finanza etica e solidale. Ha conseguito una Laurea magistrale in Filosofia presso l’Università di Torino e un Dottorato in Sociologia presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi e la Scuola Alti Studi della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con una tesi sulle banche etiche in Italia e in Francia.
- - - -
 Ethics-Finance New Deal: per una crescita sostenibile al servizio della collettività.
Ethics-Finance New Deal: per una crescita sostenibile al servizio della collettività.
Abstract - Le crisi economiche che si sono succedute negli ultimi quindici anni hanno messo in luce le fragilità e le disfunzioni dell’attuale capitalismo globalizzato. Il sentiero della crescita su cui si basa il sistema economico-sociale in cui viviamo è così disseminato da crack finanziari, da un aumento diffuso delle diseguaglianze, dalla crescita di rischi climatici e ambientali, che si impone una riflessione strutturale sulla sostenibilità di questo modello.
Il presente lavoro, partendo da un’analisi dei diversi modelli di crescita e del loro impatto sull’economia reale, si focalizza sulla difficoltà di bilanciamento tra values e profittabilità in campo finanziario, proponendo l’inserimento dell’etica nei modelli di decisione economici.
Successivamente, a partire da una rassegna delle nuove regolamentazioni attuate sia dall’ONU sia dalla BCE, si analizzeranno gli strumenti, applicati e applicabili, necessari ma non sufficienti senza un cambio di paradigma che sappia identificare la ripresa all’ integrazione di aspetti legati alla sostenibilità sociale, climatica e ambientale.
- - - - - -
 Abstract / Big Data e rigenerazione urbana Discutere di Big Data e rigenerazione urbana significa porre l’attenzione verso molteplici problematiche, ma al contempo ci permette di riflettere attorno ad una serie di opportunità con le quali verosimilmente andremo a confrontarci nei prossimi anni.
Abstract / Big Data e rigenerazione urbana Discutere di Big Data e rigenerazione urbana significa porre l’attenzione verso molteplici problematiche, ma al contempo ci permette di riflettere attorno ad una serie di opportunità con le quali verosimilmente andremo a confrontarci nei prossimi anni.
Se da un lato la Pandemia ha messo in risalto tutte le debolezze con le quali ci siamo raffrontati nella nostra quotidianità, dall’altro ci ha obbligato a fermarci e in più occasioni a mettere in discussione il modello culturale, economico e sociale che abbiamo adottato fino ad oggi (Corposanto, Molinari, 2021).
La relazionalità è cambiata, così come l’utilizzo delle nuove tecnologie, con estrema razio è facile pensare che difficilmente torneremo agli stili di vita pre-Covid-19 al termine dell’emergenza sanitaria (Molinari, 2021).
Stressare il nostro sistema economico-politico ha permesso di aprire una nuova discussione comunitaria attorno ad una ripresa economica che varca i confini europei, lambisce e coinvolge sicuramente l’occidente, ma senza dimenticare l’altra parte del mondo, con la quale difficilmente ci rapportiamo per tutta una serie di problematiche geo-politiche e non solo, ma con le quali ora è necessario aprire un dibattito comune (Quammen, 2020).Restando tra le nostre mura geo-politiche il dibattito odierno ruota attorno alla sempre più pressante richiesta di una congrua gestione del tesoretto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che necessita di un’organizzazione burocratico amministrativa mai conosciuta prima per il nostro paese.
Dal punto di vista più prettamente urbanistico, ci troviamo in un contesto storico e culturale paesaggistico complesso, ma il PNRR apre nuove strade attraverso azioni concrete.La sfida reale è quindi quella di adottare una rigenerazione urbana che supporta il concetto di “città dei 15 minuti” dove l’utilizzo dei Big Data diviene il fulcro di un comportamento eticamente responsabile orientato all’ambiente che ci circonda.
CV - Ricercatrice universitaria RtD.Ain Sociologia generale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro dove insegna Sociologia dell’ambiente e del territorio e Sociologia della scienza. Si occupa tra l’altro anche di Sociologia della salute con una particolare attenzione alla qualità della vita, alla metodologia della ricerca sociale e agli e-methods. Tra le sue pubblicazioni recenti: L’orientamento scolastico nella complessità sociale (a cura di Molinari B.) Rubbettino (2021).

Abstract - Oggi, gli imprenditori e i professionisti hanno tutte le informazioni e gli strumenti utili a scegliere di agire in modo responsabile verso una sostenibilità ambientale, economica e sociale. La comunicazione e il marketing - con i dovuti aggiornamenti - diventano braccio operativo di brand responsabili, stimolando scambi commerciali che implicano al tempo stesso scambio di valori e di vantaggi reciproci con il fine ultimo della co-creazione di benessere.
Tuttavia scelta di responsabilità non è scontata e ancora poco applicata. Essa dipende dalla consapevolezza di avere un ruolo strategico nel cambiamento di abitudini e scelte di acquisto individuali e collettive, che possono generare benessere, felicità e salute olistica. Nonché quella di essere parte stessa del processo di degrado generale delle condizioni ambientali e sociali in atto già da un paio di decenni. Solo con una presa di responsabilità avremo una nuova economia del benessere in grado di reinterpretare e applicare in modo sano capitalismo e competitività.
- - - - -
Abstract - EthicalFin NPL si occupa di gestione e recupero del credito e opera nell’ambito della cartolarizzazione bancaria. Proprio quest’ultima parolina, “cartolarizzazione bancaria”, è ciò che ci connette all’ambito della finanza e che ci fa essere qui oggi.
Nel corso del mio intervento, cercherò di spiegare brevemente che cosa è la cartolarizzazione bancaria e di cosa ci occupiamo, in modo da condividere le nostre riflessioni su cosa significa gestire i crediti NPL in maniera etica, nel nostro piccolo e nei mandati che otteniamo, ma anche un po’ più grande, condividendo una riflessione come operatori di settore su quelli che secondo noi potrebbero essere gli interventi auspicabili.
Infine, chiuderò parlando di come abbiamo inteso (e tradotto anche, in comportamenti pratici, all’interno della nostra scheda di valutazione) il valore della responsabilità all’interno della nostra filosofia aziendale.
- - - - - -

Abstract - L’importanza del ruolo delle imprese nel quadro dello sviluppo sostenibile è ormai ampiamente riconosciuta. Di conseguenza, con altrettanta frequenza si invitano le imprese a porre in essere comportamenti “responsabili” che contribuiscano a migliorare il contesto sociale e preservare l’ambiente naturale. Ma che cosa significa per un’impresa agire in modo responsabile? Quali sono gli ambiti in cui si declina tale responsabilità? E come si concilia la responsabilità sociale con il perseguimento degli obiettivi economici e di profitto?
CV
Riccardo Spinelli è Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova, dove insegna “Etica economica e responsabilità sociale delle imprese”. I suoi interessi di ricerca includono la comunicazione di sostenibilità da parte delle imprese, il turismo sostenibile, le strategie e politiche di sostenibilità delle imprese e delle destinazioni turistiche.
- - - - - -