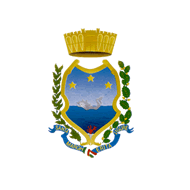«La scienza è spesso accusata di aver addensato sull’uomo pericoli terribili, fornendogli un potere eccessivo sulla natura» (K. Lorenz)
Quella riportata in esergo è una questione che va avanti dai primordi della civiltà. Sfortunatamente gli uomini non si sono mai messi d’accordo su quell’impegnativo termine «potere eccessivo», che è l’autentica chiave di volta per essere autorizzati, avendo istituito un minimo di accordo sul logo semantico (il significato delle parole che si usano), a disquisire sul logo apofantico (la verità o falsità di quel che si dice).
A sentire gli opposti contendenti (vale la pena ripeterlo: si tratta di una contesa che si perde nella notte dei tempi) ci troviamo di fronte a due posizioni assolutamente inconciliabili: per gli uni, ogni stadio del «progresso scientifico e tecnologico» ha rappresentato il momento di massimo pericolo dato l’eccessivo potere acquisito dall’uomo nei confronti della natura; gli altri, che pur molto apprezzano qualsivoglia incremento di potere dell’uomo sulla natura, continuano a lamentare l’esiguità di tale incremento e, anzi, insistono a rammaricarsi del fatto che siamo ben lontani dall’esercizio di un apprezzabile controllo del mondo naturale.
In sostanza si discute da sempre su un aggettivo relativo (eccessivo) il quale, appunto per questa sua specifica qualità grammaticale, ha bisogno di svolgere il proprio onesto lavoro fra termini messi a confronto e magari rigorosamente definiti in termini metrici. Per meglio dire, la prima questione da mettere in chiaro dovrebbe essere la seguente: quando una certa quantità (il livello dei mezzi tecnici effettivamente utilizzati per intervenire sul mondo naturale) supera (eccede da) una certa soglia? (il momento critico per cui un feed-back impazzisce e da negativo si trasforma in positivo distruggendo il sistema che dovrebbe controllare).
Già tentare di specificare un compito di questo genere è impresa titanica; voler poi prendere alla lettera la richiesta di discutere, nell’arco di qualche pagina, quattro millenni di storia intellettuale nel corso dei quali gli uomini hanno messo in discussione i pericoli insiti nel progresso delle scienze e delle tecniche è un invito a eludere il problema o a tentare l’impossibile.
Potrebbe, allora, valere la pena di tracciare un itinerario dal quale il luogo comune («la morale sprovvista di favola») della pericolosità dell’eccessivo sapere ritorni a essere una problematica meritevole di essere discussa.
Si tratta (e non è cosa da poco) di «passare dal dominio dei luoghi comuni alla regione delle idee». Per far questo è necessario ri-trasformare l’intera questione da asserto ideologico in problema scientifico. Ovviamente, questo non è il punto di partenza, ma quello di arrivo. «Credere al progresso - avvertiva Kafka nei Diari - non significa credere che un progresso vi sia già stato».
Il punto di partenza più ragionevole potrebbe essere individuato alle origini stesse della storia della civilizzazione dell’Occidente: la scienza (la conoscenza in grado di garantire la validità o l’efficacia dei propri procedimenti) promette la verità, mentre l’uomo s’attende la felicità, tutto sta vedere se verità e felicità coincidono.
Nel corso del I millennio a. C., dal Dialogo del pessimismo fino all’Ecclesiaste, ci si sente ripetere:«... quanto più cresce la scienza, tanto più crescono gli affanni e colui che aumenta la conoscenza non fa altro che aumentare il dolore» (Eccl. 1 - 18).
Ancor prima, intorno alla metà del II Millennio, nel mondo minoico-miceneo compare il Labirinto, opera tecnica di Dedalo, l’uomo di scienza in grado di trasformare il suo sapere in prodotto dell’arte; perverso e bizzarro costrutto dell’intelletto, il Labirinto è simbolo di perdizione, prefigurazione del logos e, di conseguenza, strumento della rovina. Anche gli antichi «racconti della caduta» sono al riguardo chiarissimi: il male incomincia a percorrere la terra dopo che gli uomini, abbandonata la strada della «sapienza», hanno incominciato a percorrere i sentieri della scienza.
Illuminanti sono le prime pagine del Genesi:
«Allora il serpente disse alla donna: 'No, voi non morrete, anzi Dio sa che il giorno in cui ne mangerete vi si apriranno gli occhi e sarete come Dio: conoscitori del bene e del male” [Gen. 3, 1-6] ...
Poi il Signore Iddio disse:
“Ecco, ora l’uomo è diventato come uno di noi nella conoscenza del bene e del male. Ora dunque, non stenda la mano e non colga anche l’albero della vita e ne mangi e viva in eterno” [Gen.,3, 22].
Inequivocabile il mito greco delle origini e della caduta dell’uomo; la tragica vicenda inizia dal dono prometeico del fuoco e delle arti di Efesto e di Pallade (techne e logos sono la prima scaturigine dell’ubris) e termina con la punizione divina: l’invio di Pandora («... essi riceveranno in cambio del fuoco un male di cui gioiranno») la quale apre il vaso di Zeus introducendo il male nel mondo («...sparse i mali, versando sugli uomini pianti e dolori» [Esiodo, Op. 53, sgg.]).
La letteratura religiosa (sia in ambito greco che nel mondo ebraico e semita) ripete costantemente che la scienza e la tecnica generano dolore e sono scaturigine dei mali. Dal vigoroso incedere del dialogo fra Dio e Giobbe (che ha inizio con l’ironica richiesta di Yhavè: «T’interrogherò e tu ammaestrami!» e termina con la ritrattazione di Giobbe del proprio tracotante sapere) fino all’apocrifo di Enoc (in cui è detto chiaramente che la discesa degli angeli ribelli portò agli uomini la conoscenza delle arti e delle tecniche e, di conseguenza, la rovina del genere umano: «E per la perdita dell’umanità, la loro voce si alzò fino al cielo e li accusò» [Enoc. VII]), la linea di pensiero veterotestamentaria sfocia nell’inno paolino alla carità: «Quand’anche io avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza ... se non ho la carità (agape) io non sono niente» [Cor. 13] e prosegue, per tutta l’età della Santa Romana Repubblica, come contrapposizione fra la sapienza del cuore e la conoscenza dell’intelletto: questa genera affanni e dolori, quella li lenisce e introduce alla «perfetta letizia».
Di analogo segno (pur nella diversità della cifra semantica) il discorso «sapienziale» greco: dopo le devastanti introduzioni prometeiche delle tecniche e delle arti, l’umanità ritrova la salvezza nei doni di Dioniso e Demetra
«... beato colui che ha un buon demone e conoscendo l’iniziazione degli dei vive santamente e introduce la sua anima nella schiera dionisiaca» [Eur. Bacc. 72];
«... e Demetra mostrò a tutti i riti misterici e i riti santi che non si possono trasgredire né apprendere né proferire ... Felice colui tra gli uomini viventi sulla terra che ha visto queste cose» [Pindaro, Inno a Demetra].
Sapiente, nel mondo greco arcaico, non è colui che sa attuare e utilizzare le tecniche, che eccelle in destrezza ed è capace di inventare i più diversi espedienti. Odisseo non è sapiente, perché sapienza significa gettare luce nell’oscurità da parte di chi si è concesso all’illuminazione.
La scienza e le tecniche non sono le strade che possono portare l’uomo alla realizzazione dei suoi più profondi bisogni spirituali, ma al contrario lo distolgono dal cammino della sapienza e lo portano su quello della stoltezza. I beni materiali promessi dalle tecniche sono vacui:
«Quando riflettei su tutte le operazioni che avevano eseguito le mie mani e sulla fatica che avevo durato per compierle, ecco che tutto era vanità e pascersi di vento» (Ecclesiaste, 2, 10),
e i frutti dell’umano conoscere son poca cosa di fronte alla vera Sapienza:
«Per chi teme il Signore tutto andrà a buon fine e nel giorno della fine sarà benedetto. Principio di sapienza è temere il Signore...» (Ecclesiastico, I, 43-44).
In una prospettiva di questo genere, il potere che scienza e tecnica forniscono all’uomo è comunque sempre eccessivo se esse non portano a Dio o, addirittura, lo allontanano da Lui
«... dato che ebbero tanta scienza da poter esplorare l’universo, come mai non trovarono Colui che ne è il Signore. Infelici! In cose morte essi ripongono le loro speranze» (Sapienza, 13, 9-10).
In altre parole, se il potere e la conoscenza che gli uomini hanno sopra la natura non sono intenzionati alla sfera spirituale, allora questo potere è eccessivo rispetto all’autentico scopo dell’uomo dato che lo portano fuori strada, ossia a perdersi.
Ma vi è un ulteriore significato dell’eccesso di potere: la prepotenza dell’uomo che giunge fino al punto di credere gli sia possibile opporsi alla divinità, ossia la ybris, l’insolente orgoglio, che è l’esatto contrario del biblico «temere il Signore», sinonimo di sapienza. In una delle più basilari articolazioni del pensiero religioso greco tutto questo è inequivocabilmente chiarito: quando l’uomo diventa superbo e si ingelosisce degli dei, quando l’ybris lo avvolge, allora per invidia del loro potere concepisce l’insolente intenzione di andare oltre, di rompere l’ordine fissato. E’ in quel momento che scatta la fthonos, ossia la legge del contrappasso, l’ineluttabile punizione che non può mai trasformarsi in perdono perché il suo scopo è quello di ricomporre l’ordine che l’intenzione (non l’azione) dell’uomo aveva provato a infrangere.
L’andare oltre, l’inoltrarsi nella regione del disordine, rappresenta per il mondo greco l’autentico tentativo di sopraffazione del chaos nei confronti del cosmo; significa l’aver sconfinato nelle terre dove non v’è la presenza del dio e, di conseguenza, dove non può esservi la sua immagine: l’uomo.
Sotto questa luce (e nei due sensi appena delineati) la derivazione del pericolo dal livello del potere sulla natura è motivata sia dall’aver chiarito, nel primo caso, che lo scopo precipuo dell’uomo è radicalmente diverso dal dominio sul mondo naturale (il sapere non intenzionato alla sfera spirituale è vano e dannoso) che dall’aver fissato, nel secondo caso, i limiti oltre i quali l’umano agire travalica le proprie possibilità (dove l’andare oltre significa autodistruzione). Ovviamente, non metterebbe neppur conto di dirlo, non è qui posta in discussione la legittimità dell’attività noetica e pratica dell’uomo essenziali per il raggiungimento e il mantenimento di un livello di vita adeguato, ma il fatto che questo sia il suo fine unico e ultimo e che tale attività pretenda di imporre le leggi dell’utilità (per l’uomo) in contrapposizione e a scapito dell’ordine naturale. Nate agli albori della storia, queste due posizioni avrebbero potuto fornire ottime armi all’accusa contro gli eccessi della scienza e delle tecniche. Sfortunatamente sono state sottoposte a tali e tante volgarizzazioni e sono finite nelle mani di tali e tanti ideologi da risultare ormai prive della loro forza originaria.
Tale forza potrebbe essere sintetizzata in due punti:
- a) il destino dell’uomo presenta un incontestabile valore di trascendenza rispetto al mondo fisico e, quindi, tradire tale destino significa tradire l’uomo;
- b) l’universo è retto da un ordine necessario che è condizione della propria sopravvivenza, ogni infrazione di tale armonia (sia pur finalizzata al benessere dell’umanità) introduce il disordine nell’intero sistema, compresi i suoi sottoinsiemi che sono i sistemi sociali.
La critica più assidua cui, in prima istanza, sono state sottoposte queste posizioni è sintetizzabile nel fatto che esse impedirebbero il progresso e, in cambio, non sarebbero in grado di mantenere le loro specifiche promesse: l’ordine fisico e l’armonia etica. In secondo luogo, all’accusa che il livello dei mezzi tecnico-scientifici effettivamente utilizzati per intervenire sul mondo naturale può superare la soglia del pericolo, si risponde affermando che tale argomento non ha ragione di essere in quanto gli eventi della storia avvengono nel senso più desiderabile realizzando una crescente perfezione, ossia il progresso della scienza e della tecnica corre di pari passo al progresso dell’umanità. Tutto sta, ancora una volta, a mettersi d’accordo sul significato dei termini usati; in questo caso il termine incriminato è quello di progresso.
Il concetto di progresso è una delle nozioni più dense di significato, di implicazioni profonde e di suggestioni che l’uomo abbia coniato. Esso comporta una precisa concezione della storia o meglio una chiara definizione del posto che l’uomo ha nel processo del divenire del mondo. Tale concezione deve essere sia descrittiva che normativa, comporta tanto una teorizzazione storica che filosofica. Essa implica che siano elaborate precise nozioni circa il progresso della conoscenza, i suoi usi, le sue possibilità, il suo valore e le sue fonti. Ma dato che la conoscenza, pur presentandosi con un incontestabile valore noetico, può avere esiti pratici (le tecniche), è automatico porsi le stesse domande anche per le tecniche, aggiungendo tutta una serie di problematiche conseguenti di genere etico e sociale che possono portare a questioni circa il progresso o il regresso della felicità, del benessere sociale, del potere politico e della virtù.
Non va dimenticato che tale concetto implica che sia messo in chiaro qualeè la direzione desiderabile per poter parlare di progresso e non di regresso, di stasi o di deviazioni. Sono, inoltre, richiesti giudizi di valore d’ordine deontologico ed etico su ciò che dovrebbe essere e su ciò che si deve fare in rapporto a se stessi, ai propri simili, alla natura e a Dio.
«In altri termini, - scrive AlistairCrombie - il concetto di progresso è a un tempo profano e sacro, a un tempo epistemologico, cosmologico e religioso, in quanto implica convinzioni circa la conoscenza, circa ciò che esiste, e inoltre circa le origini, le attese e le responsabilità dell’uomo all’interno di quello che è accettato come lo schema della conoscenza e dell’esistenza».
Sotto questa luce l’accusa di impedire il progresso avrebbe poco senso se non venisse detto di quale progresso si tratta e se vale la pena.
“Beatus nemodici potest extra veritatem proiectus” diceva Seneca “Nessuno lontano dalla verità può dirsi felice”ma eudaimonìa (beatitudo)[eu (bene) e daimon (demone)]che per Platone è l’aver conosciuto il bene e il vero e quindi posseduta la virtù, non sarebbe stato possibile astenersi dall'agire rettamente realizzando il giusto che era di per sé "piacevole" in quanto generava la eudemonia, la serenità dell'animo. Garantita, però, dalla Repubblica guidata dai filosofi che soli sono in grado di creare le condizioni propizie per la felicità dei cittadini (Platone, Repubblica, IV 420 B).
E questa è una vera Utopia.
Ma prima eudemonia veniva usata da Talete come “colui che ha un corpo sano, buona fortuna e un anima bene educata” [Diog. L. I,1, 37], da Erodoto per indicare una vita sana e florida e da Esiodo per indicare una vita “appagata e prospera", ossia per poter vivere felici bisognava nascere con un "buon demone" e, quindi, essere fortunati ossia favoriti dalla sorte.
«Eraclito ha detto che se la felicità risiedesse nei piaceri corporali, diremmo che i buoi sono felici quando hanno dei ceci da mangiare»Alberto Magno, De vegetalibus libri VII, Reimer, Berlin, 1867 VI, 401, però un bue che non ha niente da mangiare è sicuramente infelice.